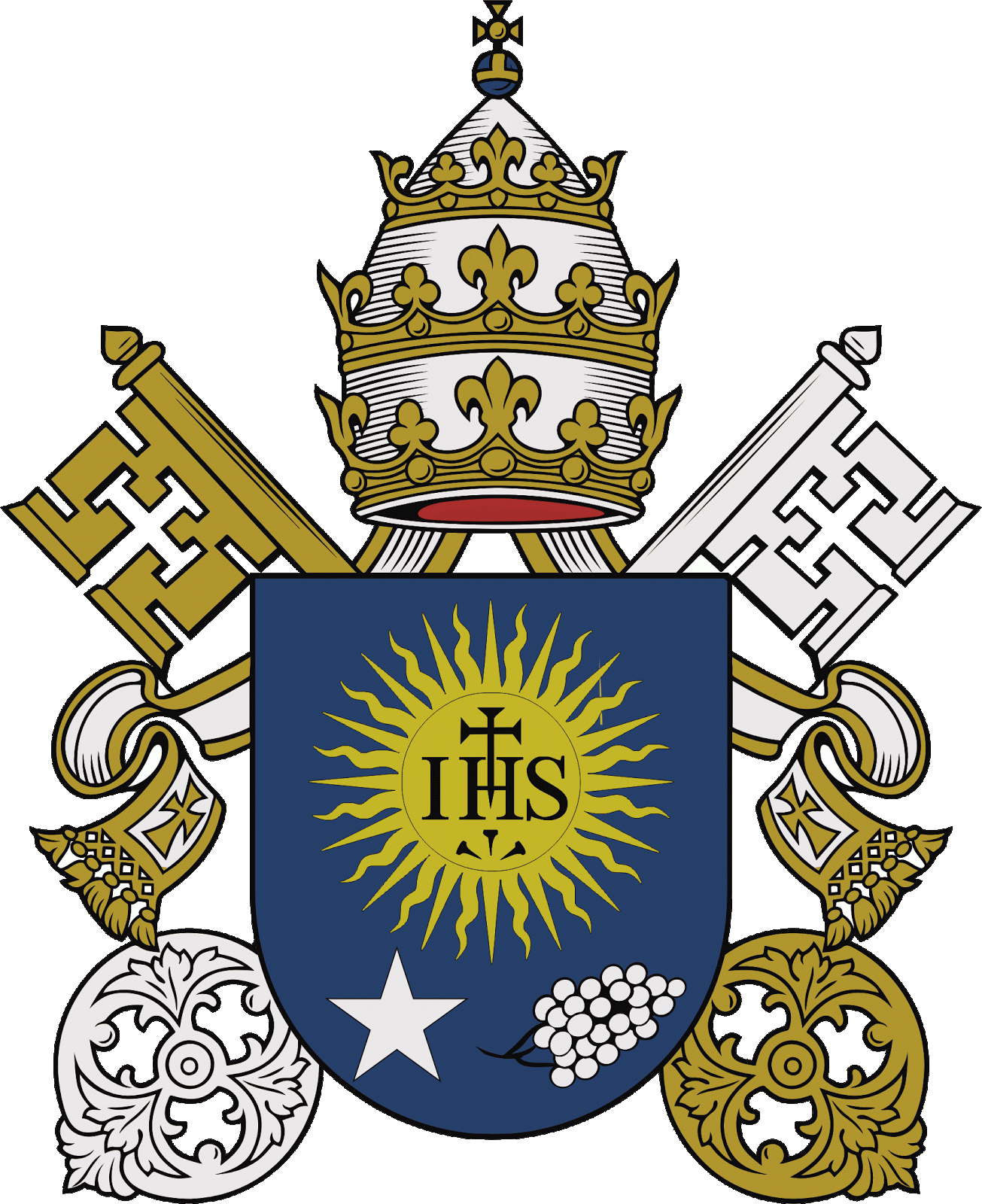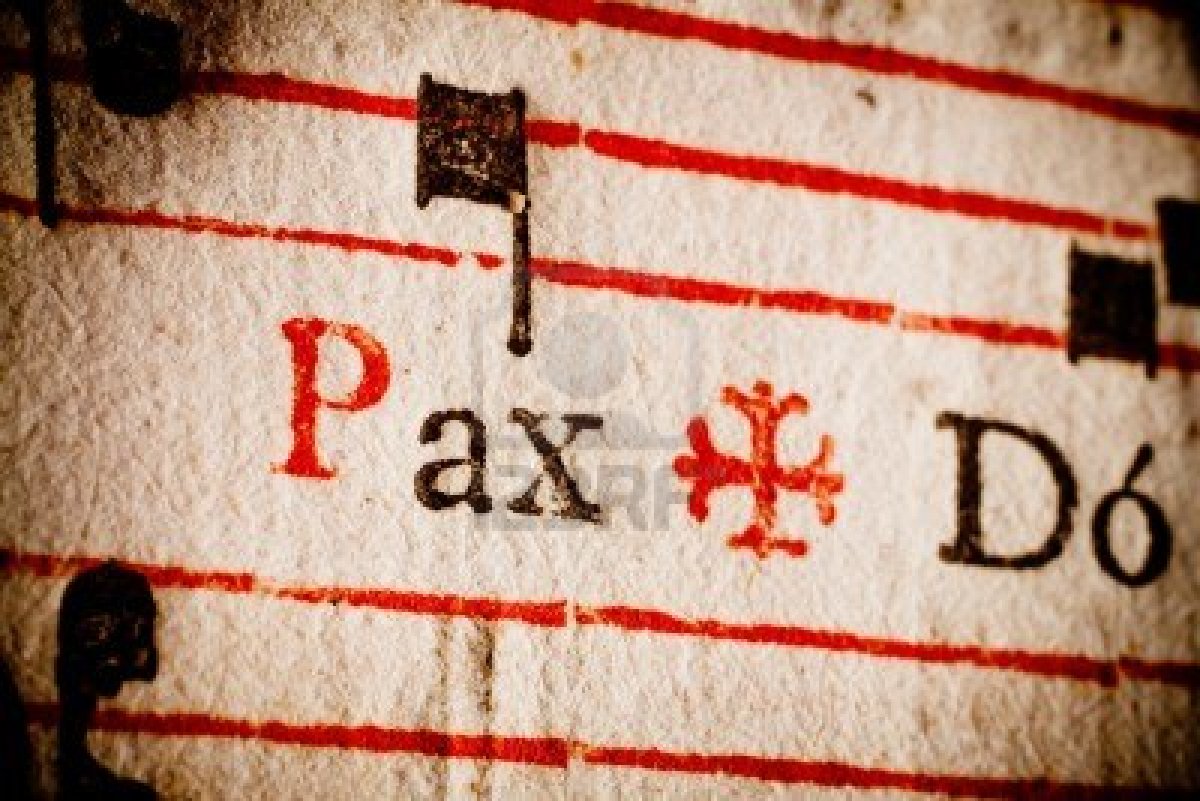È stato giustamente osservato che la Messa, come pure il Breviario antico, non ha autore poiché di gran parte dei suoi testi non si può dire quando abbiano avuto origine e quando abbiano trovato una collocazione definitiva. Ciascuno perciò «percepiva che essa era qualcosa di eterno e non costruito da mano umana» (M. Mosebach). È certo, infatti, che il Messale Romano – come afferma il beato Ildefonso Schuster – rappresenta nel suo complesso «l’opera più elevata e importante della letteratura ecclesiastica, quella che riflette più fedelmente la vita della Chiesa, il poema sacro al quale han posto mano cielo e terra».
« Il nostro Canone – afferma Adrien Fortescue – è intatto, come tutto lo schema della Messa. Il nostro Messale è ancora quello di san Pio V. Dobbiamo ringraziare che la sua commissione sia stata così scrupolosa da mantenere o restaurare l’antica tradizione romana. Essenzialmente il Messale di san Pio V è il Sacramentario Gregoriano, modellato sul libro gelasiano che a sua volta dipende dalla collezione leonina. Troviamo le preghiere del nostro Canone nel trattato De Sacramentis e riferimenti al Canone stesso nel IV secolo. Così la nostra Messa va indietro, senza cambiamenti essenziali, all’epoca nella quale per la prima volta si sviluppò dalla Liturgia più antica. […] nonostante i problemi irrisolti, nonostante i cambiamenti successivi, non esiste nella Cristianità un altro rito così venerabile come il nostro».
Prima di addentrarci nello specifico del tema, ci par opportuno ricordare e riaffermare alcuni principi fondamentali della sacra Liturgia che sembrano esser caduti nell’oblio con conseguenze così aberranti da ridurre le sacre Sinassi a celebrazioni «etsi Deus non daretur». Il che significa de facto la morte della Liturgia.
Il primo principio è che la Liturgia non è, non è mai stata né potrà mai essere, l’espressione del sentimento del fedele nei confronti del suo Creatore. Essa è invece l’adempimento da parte del fedele di un suo dovere nei confronti di Dio, ch’egli deve esprimere conformemente agli stessi insegnamenti divini. È il cosiddetto ius divinum, ossia il diritto di Dio ad essere adorato come Egli ha stabilito. La Liturgia non è una qualsiasi preghiera che il fedele rivolge spontaneamente a Dio, bensì “la” preghiera ufficiale della Chiesa: non v’è in essa nulla da inventare, né da innovare, né da adattare. «La Liturgia non è mai proprietà privata di qualcuno, né del celebrante, né della comunità» (enciclica Ecclesia de Eucharistia n. 52). Essa non è «l’espressione della coscienza di una comunità, del resto sparsa e mutevole». In forza di ciò, la Liturgia cattolica non è e non può essere “creativa”. Non lo può essere per la semplice ragione che non è un prodotto umano, ma opera di Dio, come ha ribadito a più riprese il Santo Padre. È interessante evidenziare a questo riguardo come già nel I secolo la Liturgia – benché ancora allo stato primitivo – avesse un proprio ordine che i cristiani ritenevano risalente a Cristo stesso. Il Fortescue nota che fin dal suo nascere la preghiera dei primi cristiani non è mai consistita in incontri organizzati a proprio piacimento. Lo dimostra con evidenza solare la prima lettera di san Clemente ai Corinti in cui si legge: «1.Dobbiamo fare con ordine tutto quello che il Signore ci comanda di compiere nei tempi fissati. 2.Egli ci prescrisse di fare le offerte e le liturgie, e non a caso o senz’ordine, ma in circostanze ed ore stabilite. 3. Egli stesso con la sua sovrana volontà determina dove e da chi vuole siano compiute, perché ogni cosa fatta santamente con la sua santa approvazione sia gradita alla sua volontà. 4.Coloro che fanno le loro offerte nei tempi fissati sono graditi e amati. Seguono le leggi del Signore e non errano. 5. Al gran sacerdote sono conferiti particolari uffici liturgici, ai sacerdoti è stato assegnato un incarico specifico e ai leviti incombono propri servizi [Gli Ordini minori aboliti da Paolo VI, Ministeria quaedam -ndr]. Il laico è legato ai precetti laici» (cap. XL). Sin dal I secolo v’è dunque nel Culto Divino un ordine ben stabilito ed una gerarchia che si ritengono provenire dal Signore.
In secondo luogo la Liturgia si àncora nella Tradizione, che è fonte della Rivelazione al pari della Sacra Scrittura. «La Liturgia – afferma il grande liturgista dom Guéranger – è la medesima Tradizione al suo più alto grado di potenza e solennità»; è «il pensiero più santo della sapienza della Chiesa per il fatto di essere esercitata dalla Chiesa in unione diretta con Dio nella confessione (di fede), nella preghiera e nella lode». La Liturgia, in altri termini, è il Dogma pregato.
I nemici della Chiesa conoscono a fondo questo principio. Essi sanno bene che il popolo di Dio è istruito, anzitutto, dalle e nelle sacre Sinassi. Demolite quelle, è demolita la Fede.
Con sguardo profetico dom Guéranger aveva compreso che l’odio della Liturgia cattolica è un comune denominatore dei vari novatores succedutisi nel corso dei secoli, i quali per attaccare il Dogma cattolico iniziano la loro feroce opera di distruzione dalla Liturgia. «Il primo carattere dell’eresia antiliturgica – scrive – è l’odio della Tradizione nelle formule del culto divino. Non si può contestare la presenza di tale specifico carattere in tutti gli eretici, da Vigilanzio fino a Calvino, e il motivo è facile da spiegare. Ogni settario che vuole introdurre una nuova dottrina si trova necessariamente in presenza della Liturgia, che è la Tradizione alla sua più alta potenza, e non potrà trovare riposo prima di aver messo a tacere questa voce, prima di avere strappato queste pagine che danno ricetto alla fede dei secoli trascorsi. Infatti, in che modo si sono stabiliti e mantenuti nelle masse il luteranesimo, il calvinismo, l’anglicanesimo? Per ottenere questo non si è dovuto far altro che sostituire nuovi libri e nuove formule ai libri e alle formule antiche, e tutto è stato consumato».
La Tradizione è anteriore alla Sacra Scrittura e abbraccia un campo assai più vasto. Essa è una fonte della Rivelazione distinta dalle Sacre Scritture, fonte che merita la medesima fede (così il Concilio di Trento e il Concilio Vaticano I). San Vincenzo di Lérins (†450 ca) riteneva come genuina tradizione apostolica ciò che soddisfaceva contemporaneamente a tutte e tre le seguenti condizioni: Quod semper, quod ab omnibus, quod ubique, ossia ciò che è stato creduto in ogni tempo, da tutti i fedeli e in ogni luogo.
La Tradizione è presente nella Liturgia, che contiene le preghiere e i riti del culto pubblico e dei Sacramenti. Non a caso sin dai primi decenni del 400 si trova citata la massima “legem credendi lex statuat supplicandi“, e cioè la preghiera liturgica (lex supplicandi) sia fonte (statuat) di cognizione teologica (legem credendi).
Questa massima millenaria – sulla quale torneremo – indica la vitale importanza e la grandissima utilità di mantenere inalterata e in uso la Liturgia tradizionale, e in particolare quella della Santa Messa, a salvaguardia della Fede. Indica anche che, con buona pace della creatività e dei presbiteri e dei fedeli, la creazione di nuove liturgie può facilmente corrompere la Fede (e difatti la corrompe) insinuando riti e preghiere privi di quel rigore teologico che ne garantisce un’interpretazione univoca e ortodossa.
In questo senso l’ostracismo al Messale di san Pio V, sintesi ed espressione d’una tradizione millenaria che rimonta – attraverso diversi stadi – ai tempi apostolici. costituisce ancor oggi un evidente segno di quell’odio alla Tradizione che da sempre ha caratterizzato la mente dei novatores d’ogni epoca.
«Dio – afferma dom Guéranger – ha tanto amato il mondo da donargli il suo unico Figlio affinché Questi lo istruisse nel compimento dell’opera liturgica. Dopo essere stata annunziata e prefigurata per quaranta secoli, una preghiera divina è stata offerta, un sacrificio divino è stato compiuto, e, ancora adesso e per l’eternità, l’Agnello immolato sin dall’inizio del mondo si offre sull’altare sublime del cielo e rende in una maniera infinita all’ineffabile Trinità tutti i doveri di religione, a nome dei membri di cui egli è il Capo».
Bisogna però considerare che – anche prima dell’Incarnazione del Verbo – il mondo non è mai stato senza Liturgia: poiché, come la Chiesa risale al principio del mondo, secondo la dottrina di sant’Agostino, la Liturgia risale a questo medesimo principio.
Nell’Antico Testamento la Liturgia è esercitata dai primi uomini nel principale e più augusto dei suoi atti, il sacrificio. Basti pensare ai sacrifici di Caino ed Abele, a quello di Noè, che lo perpetua dopo il diluvio. Abramo, Isacco, Giacobbe, offrono sacrifici di animali e innalzano pietre per l’altare che adombrano l’altare e il Sacrificio futuro. Poi Melchisedech, avvolto nel mistero d’un Re-Pontefice, tenendo nelle sue mani il pane ed il vino offre un olocausto pacifico, anch’esso figura del Sacrificio di Cristo.
Durante tutta quest’epoca primitiva, le tradizioni liturgiche non sono fluttuanti ed arbitrarie, ma precise e determinate. È evidente che esse non sono invenzione d’uomo, ma imposte da Dio stesso; difatti il Signore loda Abramo poiché aveva osservato non solo le sue leggi e i suoi precetti, ma anche le sue cerimonie.
Quando venne la pienezza dei tempi, il Verbo si fece carne ed abitò in mezzo a noi: Egli venne non per distruggere, ma compiere e perfezionare anche le tradizioni liturgiche. «Dopo la sua nascita, fu circonciso, offerto al tempio, riscattato. Dall’età di dodici anni, adempì la visita al Tempio, e, più tardi, lo si vide frequentemente venire ad offrire la sua preghiera. Compì la sua missione con il digiuno di quaranta giorni; santificò il sabato; consacrò con il suo esempio la preghiera notturna. Nell’Ultima Cena, in cui celebrò la grande Azione liturgica, e provvide al suo compimento futuro fino alla fine dei secoli, iniziò con la lavanda dei piedi, che i Padri hanno chiamato un mistero, e finì con un inno solenne, prima di uscire per andare al monte degli Ulivi. Poche ore dopo, la sua vita mortale, la quale non era che un grande atto liturgico, si concluse nell’effusione del Sangue sull’altare della croce; il velo dell’antico tempio, squarciandosi, aprì come un passaggio ai nuovi misteri, proclamò un nuovo tabernacolo, un’arca d’alleanza eterna, e da allora in poi la Liturgia cominciò il suo periodo completo in quanto al culto della terra» (P. Guéranger).
L’opera di Gesù Cristo
È necessario e fondamentale – nell’ambito dello studio della sacra Liturgia – stabilire se il Signore Gesù abbia fissato – almeno implicitamente – le grandi linee del sistema liturgico che si riferiscono alla sostanza del Culto cristiano.
Sulle orme dell’Aquinate, il quale afferma che «per suam passionem Christus initiavit ritum christianæ religionis», si può subito osservare che fu Cristo ad inaugurare il Culto cristiano iniziandolo incruento nell’Ultima Cena per consumarlo nel sangue sul Calvario. «A Lui dobbiamo, non solo l’istituzione della grazia propria dei sette Sacramenti, come ebbe a definire il Tridentino, ma anche il rito esteriore dei tre più importanti di essi, il Battesimo, l’Eucaristia, la Penitenza. Del Battesimo precisò la materia e la forma […]. Dell’Eucaristia fissò pure la materia – il pane ed il vino – e la forma nelle parole consacratorie da lui pronunciate durante l’ultima Cena: “Hoc est corpus meum… hic est sanguis meus“. […] Inoltre, siccome l’Eucaristia doveva essere il sacrificio della nuova Legge e per conseguenza l’atto liturgico più importante, volle ancora stabilire le sostanziali modalità con le quali doveva esser celebrata». In base alla narrazione dei Sinottici si desume che il Signore Gesù:
- istituì l’Eucaristia gratia agens, cioè pronunciando un formula eucaristica o di ringraziamento, servendosi probabilmente delle consuete eulogie giudaiche proprie del rituale di Pasqua ma integrate per quell’eccezionale circostanza; e prescrisse che il suo atto fosse ripetuto.
- Impose agli Apostoli che, nel rinnovare quanto Egli aveva fatto, lo commemorassero: «Hoc facite in meam commemorationem», ovvero, come precisa meglio san Paolo, proclamassero la sua morte: «Mortem Domini annuntiabitis donec veniat» (1Cor, 11,26).
- Volle che l’oblazione sacrificale commemorativa che gli Apostoli dovevano perpetuare mantenesse, come Egli aveva fatto, la forma conviviale. Si trattava dunque d’un banchetto sacrificale al quale i credenti partecipavano con la manducazione della mistica Vittima.
È lecito chiedersi, a questo punto, se Gesù Cristo, durante la sua vita terrena, abbia dato altre norme liturgiche. Possiamo rispondere affermativamente, malgrado la difficoltà a stabilire con esattezza quali di esse effettivamente rimontino fino a Lui. Infatti:
- gli Atti osservano che Gesù, nel tempo intercorso fra la Risurrezione e l’Ascensione, si fece vedere molte volte agli Apostoli «loquens de regno Dei». Ora, una delle tradizioni più antiche della Chiesa vuole che in quei frequenti convegni, Egli, fra l’altro, abbia fissato anche molte particolarità del Culto. Non aveva Egli detto prima di morire: «Ho molte cose da dirvi che ora non potete sostenere?». Eusebio riferisce che sant’Elena edificò sul monte degli Olivi una piccola chiesa in una specie di caverna, dove, secondo un’antica tradizione, « discipuli et apostoli, [ ..] arcanis mysteriis initiati fuerunt». Il Testamentum Domini (V sec.), nel «giorno stesso della Risurrezione, induce gli Apostoli a chiedere al Signore «quoniam canone, ille (scil. qui Ecclesiæ præest) debeat constituere et ordinare Ecclesiam […], quomodo sint mysteria Ecclesiæ tractanda» (con quale regola colui che è a capo della Chiesa deve costituire ed ordinare la Chiesa […] in che modo debbano essere trattati i misteri della Chiesa); e Gesù risponde spiegando loro in dettaglio, le varie parti della Liturgia. Questa tradizione è pure accolta da san Leone il quale afferma che «quei giorni che vi furono tra la Risurrezione e l’Ascensione non passarono oziosamente, ma in essi furono confermati i Sacramenti e furono rivelati grandi misteri». E Sisto V la ricorda nella bolla Immensa: «Quella norma di credere e di pregare che Cristo ha insegnato ai suoi discepoli durante uno spazio di quaranta giorni, non c’è nessuno dei cattolici che ignori che Egli l’ha affidata per loro tramite alla sua Chiesa perché fosse custodita e sviluppata».
- San Clemente papa, discepolo degli Apostoli (†99), scrivendo alla Comunità di Corinto, accenna – come abbiamo già riportato – a positive prescrizioni del Signore circa l’ordine da seguirsi nelle offerte, nella gerarchia e nei tempi della Liturgia.
- San Giustino, dopo aver descritto tutto l’ordine della sinassi eucaristica, asserisce che questa viene celebrata in Domenica, perché in tal giorno Nostro Signore, « apostolis et discipulis visus, ea docuit, quae vobis quoque consideranda tradidimus». Vuol dire dunque che le parti principali della Messa si facevano allora rimontare al Magistero di Cristo nel giorno della sua Risurrezione. Concediamo volentieri che l’asserzione sia generica; ma tanto Giustino quanto l’Anonimo del Testamentum Domini riflettono evidentemente una tradizione diffusa, antica e nient’affatto inverosimile. Del resto, l’uniformità stessa che nel campo liturgico si riscontra presso le Comunità cristiane dei primi due secoli, suppone un principio d’autorità, un metodo d’azione, cioè una organizzazione primitiva che dovette far capo più che agli Apostoli a Cristo medesimo».
La Liturgia al tempo degli Apostoli
Se dunque il Signore ha tracciato le linee fondamentali del Culto liturgico cristiano, è da credere che, per quanto Egli non ha definito, abbia lasciato grande libertà all’iniziativa illuminata degli Apostoli, che aveva investito della sua stessa divina missione ed ai quali aveva impartito le necessarie facoltà costituendoli non solo propagatori della Parola evangelica, ma anche ministri e dispensatori dei Misteri. Il potere liturgico era fondato e dichiarato perpetuo per vigilare alla custodia del deposito dei Sacramenti e delle altre osservanze rituali che il Pontefice supremo aveva istituito.
Gli Apostoli continuano dunque a stabilire e promulgare un insieme di riti. Ecco perché il Concilio di Trento, trattando nella sua 22ma sessione delle cerimonie auguste del Santo Sacrificio della Messa, dichiara che bisogna rapportare all’istituzione apostolica le benedizioni mistiche, i ceri accesi, le incensazioni, gli abiti sacri, e generalmente tutti i particolari atti a rivelare la maestà di questo grande Atto, e a portare l’anima dei fedeli alla contemplazione delle cose sublimi nascoste in questo profondo Mistero, per mezzo di questi segni visibili di religione e di pietà.
«Questo sacro Concilio osserva dom Guéranger – non era arrivato a produrre quest’affermazione per qualche congiuntura incerta, dedotta da premesse vaghe: esso parlava come parlavano i primi secoli. Esso invocava la tradizione primitiva, ossia apostolica, così come l’aveva eloquentemente invocata Tertulliano, sin dal III secolo […]. Anche san Basilio segnala la tradizione apostolica come fonte delle stesse osservanze, alle quali aggiunge, come esempio, le seguenti: pregare verso l’oriente, consacrare l’Eucaristia nel mezzo di una formula di invocazione che non si trova registrata né in san Paolo, né nel Vangelo; benedire l’acqua battesimale e l’olio dell’unzione, ecc. E non solo san Basilio e Tertulliano, ma tutta l’antichità, senza eccezione, confessa espressamente questa grande regola di sant’Agostino, divenuta banale a forza d’essere ripetuta: “È molto ragionevole credere che una prassi conservata da tutta la Chiesa e non istituita dai Concili, ma sempre conservata, non può averla tramandata che l’autorità degli Apostoli“» (Guéranger).
Ma se gli Apostoli devono essere incontestabilmente considerati come i creatori di tutte le forme liturgiche universali, essi hanno pure dovuto adattare il rito, nelle sue parti mobili, ai costumi dei Paesi, al genio dei popoli, per facilitare la diffusione del Vangelo: da qui le differenze che regnano tra alcune Liturgie d’Oriente, che sono l’opera più o meno diretta di uno o più Apostoli, e la Liturgia d’Occidente, di cui una, quella di Roma, deve riconoscere san Pietro quale suo principale autore.
È certo che il Principe degli Apostoli, colui che aveva ricevuto da Cristo medesimo il “potere delle chiavi”, non ha potuto essere estraneo all’istituzione o regolamento delle forme generali di Liturgia che i suoi fratelli portavano in tutto il mondo. «Dal momento in cui noi ammettiamo il suo potere di capo, dobbiamo ammettere, di conseguenza, la sua influenza principale in ciò come in tutto il resto, e riconoscere, con sant’Isidoro, che si deve far risalire a san Pietro, come istitutore, ogni ordine liturgico che si osserva universalmente in tutta la Chiesa. In secondo luogo, quanto alla Liturgia particolare della Chiesa di Roma, il solo buon senso ci fa comprendere che questo Apostolo non ha potuto dimorare a Roma, in quei lunghi anni, senza preoccuparsi di una materia così importante, senza stabilire, nella lingua latina e per il servizio di questa Chiesa, che egli rendeva per libera scelta madre e maestra di tutte le altre, una forma che, in considerazione delle varianti che necessitava la differenza dei costumi, del genio e delle abitudini, si confacesse almeno a quelle che egli aveva istituite e praticate a Gerusalemme, ad Antiochia, nel Ponto e nella Galazia» (Guéranger).
Bisogna tuttavia tener conto che la formazione della Liturgia attraverso gli Apostoli si è compiuta progressivamente. San Paolo, nella sua prima Lettera ai Corinti, ci mostra questa nuova Chiesa già in possesso dei Misteri del Corpo e del Sangue del Signore; tuttavia – con le parole « Caetera cum venero disponam» – dimostra di voler dare disposizioni più precise quanto alle cose sacre. «Tale è il senso che i santi Dottori hanno costantemente dato a queste parole che terminano il passo di questa Lettera dove si parla dell’Eucaristia: san Girolamo, nel suo commento succinto su questo passo, si spiega così: “Caetera de ipsius Mysterii Sacramento“. Sant’Agostino sviluppa ulteriormente questo pensiero nella sua lettera ad Januarium: “Queste parole – dice – danno ad intendere che, allo stesso modo che egli aveva in questa lettera, fatto allusione agli usi della Chiesa universale (sulla materia e l’essenza del Sacrificio), egli istituì subito (a Corinto) questi riti in cui la diversità dei costumi non ha affatto ostacolato l’universalità“».
Attingendo dagli Atti e dalle Lettere degli Apostoli, come pure dalle testimonianze della tradizione dei primi cinque secoli, si possono – a grandi linee – ricostruire questi riti generali che, per la loro stessa generalità, devono essere ritenuti apostolici, secondo la regola di sant’Agostino sopra citata.
Il Sacrificio eucaristico nell’Evo apostolico
Dal racconto degli Atti degli Apostoli si desume l’esistenza di un rituale, semplice sì, ma fisso, e sostanzialmente completo, seguito uniformemente dagli Apostoli e dai loro collaboratori nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo, della Cresima, degli Ordini sacri, dell’Olio per gli infermi. Né si possono ignorare alcune antiche e preziose tradizioni, esistenti in talune chiese fondate dagli Apostoli, secondo le quali la Liturgia ivi vigente era un patrimonio ricevuto dagli stessi Apostoli. Tale la Liturgia di san Marco per la chiesa d’Alessandria; di san Giacomo per quella d’Antiochia, di san Pietro per la Romana. E sant’Ireneo, che per mezzo di san Policarpo si riannoda alla tradizione efesina di san Giovanni evangelista, accennando all’istituzione della Santissima Eucaristia, dichiara che la forma dell’oblazione del Santo Sacrificio, la Chiesa l’ebbe dagli Apostoli: « E parimenti… [Cristo] ha affermato che il calice è il suo sangue e ha insegnato il nuovo sacrificio [del nuovo Testamento] che la Chiesa, ricevendolo dagli Apostoli, offre a Dio in tutto il mondo» (citato da M. Righetti in Manuale di storia liturgica). Non diversamente si esprime san Giustino nella sua famosa Apologia (1,66): «Il Cristo ha prescritto di offrire; lo hanno prescritto a loro volta gli Apostoli, e noi facciamo a riguardo dell’Eucarestia ciò che abbiamo appreso dalla loro tradizione».
È evidente che, in campo liturgico, la prima preoccupazione degli Apostoli fu quella di regolare la celebrazione della divina Eucaristia. Non a caso la Frazione del Pane compare dalla prima pagina degli Atti degli Apostoli, e san Paolo, nella prima lettera ai Corinti, insegna il valore liturgico di quest’atto.
Ma il culto e l’amore che i santi Apostoli portavano a Colui con il quale questa Frazione del Pane li metteva in rapporto, li obbligava, secondo l’eloquente nota di san Proclo di Costantinopoli, di circondarlo di un insieme di riti e di preghiere sacre che non poteva compiersi che in un tempo abbastanza lungo: e questo santo Vescovo non fa che seguire in ciò il sentimento del suo glorioso predecessore, san Giovanni Crisostomo. Innanzitutto questa celebrazione, per quanto era possibile, aveva luogo in una sala dignitosa e ornata; poiché il Salvatore l’aveva celebrata così, nell’Ultima Cena, caenaculum grande, stratum» (Guéranger). Il luogo della celebrazione era costituito da un altare: già non era più una tavola. L’autore della Lettera agli Ebrei lo dice con enfasi: «Altare habemus», abbiamo un altare (Eb 13,10).
Ecco come dom Guéranger – sulla base delle Lettere degli Apostoli e delle testimonianze patristiche – ricostruisce una Sacra Sinassi al tempo degli Apostoli. Una volta riuniti i fedeli nel luogo del Sacrificio, il Pontefice, nell’epoca apostolica, presiedeva innanzitutto alla lettura delle Epistole degli Apostoli, alla recita di qualche passo del santo Vangelo, che ha formato sin dall’origine la Messa dei Catecumeni; e non bisogna cercare altri istitutori di questo uso che gli Apostoli stessi. San Paolo lo conferma in più di un’occasione. Questa ingiunzione apostolica ebbe autorità di legge subito, poiché nella prima metà del II secolo, il grande apologista san Giustino attesta la fedeltà con cui la si seguiva, nella descrizione che egli ha dato della Messa del suo tempo (cf Apologia II). Tertulliano e san Cipriano confermano la sua testimonianza.
Quanto alla lettura del Vangelo, Eusebio insegna che il racconto delle azioni del Salvatore, scritto da san Marco, fu approvato da san Pietro per essere letto nelle Chiese: e san Paolo fa allusione a questo stesso uso, quando, designando san Luca, fedele compagno dei suoi pellegrinaggi apostolici, lo definisce come «il fratello che ha lode in tutte le Chiese a motivo del vangelo» (2Cor 8,18).
Il saluto al popolo con queste parole: «Il Signore sia con voi», era in uso sin dall’antica legge. Booz lo rivolge ai suoi mietitori (cf Rt 2,4) ed un profeta ad Asa, re di Giuda (cf 2Cr 15,2). «Ecce ego vobiscum sum», dice Cristo alla sua Chiesa (Mt 28,20). Così la Chiesa mantiene questo uso degli Apostoli, come prova l’uniformità di questa pratica nelle antiche Liturgie d’Oriente e d’Occidente, secondo il chiaro insegnamento del primo concilio di Braga.
La Colletta, forma di preghiera che riassume i voti dell’assemblea, prima dell’oblazione stessa del Sacrificio, appartiene anch’essa all’istituzione primitiva, come dimostra la concordanza di tutte le Liturgie. La conclusione di questa orazione e di tutte le altre Liturgie con queste parole: «Nei secoli dei secoli», è universale, sin dai primi giorni della Chiesa. Quanto all’uso di rispondere Amen, non v’è dubbio che risalga ai tempi apostolici. San Paolo stesso ne fa allusione, nella sua prima epistola ai Corinti (cf 14,16).
Nella preparazione della materia del Sacrificio, ha luogo l’unione dell’acqua con il vino che deve essere consacrato. Quest’uso d’un così profondo simbolismo, secondo san Cipriano, risale fino alla tradizione stessa del Signore. Le incensazioni che accompagnano l’oblazione sono state riconosciute essere di istituzione apostolica dal Concilio di Trento.
Lo stesso san Cipriano ci dice che fin dalla nascita della Chiesa, l’Atto del Sacrificio era preceduto da un Prefazio; che il sacerdote gridava: Sursum corda, a cui il popolo rispondeva: Habemus ad Dominum. E san Cirillo, parlando ai catecumeni della Chiesa di Gerusalemme, Chiesa più d’ogni altra di fondazione apostolica, spiega loro l’altra acclamazione: «Gratias agamus Domino Deo nostro! Dignum et iustum est»!
Segue il Trisagio: «Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus»! Il profeta Isaia, nell’Antico Testamento, lo sentì cantare ai piedi del trono di Jahvè; nel Nuovo, il profeta di Pathmos lo ripete così come l’aveva sentito risuonare presso l’altare dell’Agnello. Questo grido d’amore e di ammirazione, rivelato alla terra, doveva trovare un’eco duratura nella Chiesa cristiana. Tutte le Liturgie lo riconoscono, e si può ben garantire che il Sacrificio eucaristico non è mai stato offerto senza che esso vi fosse proferito.
Quindi si apre il Canone. « E chi oserà non riconoscere la sua origine apostolica?», si chiede dom Guéranger. Gli Apostoli non potevano lasciare mutevole ed arbitraria questa parte principale della Liturgia sacra. Se hanno regolamentato molte cose secondarie, tanto più avranno determinato le parole e i riti del più temibile e fondamentale di tutti i misteri cristiani. « È dalla tradizione apostolica – dice il papa Vigilio nella sua lettera a Profuturo – che noi abbiamo ricevuto il testo della preghiera del Canone».
Dopo la consacrazione, mentre i doni santificati stanno sull’altare, trova la sua collocazione l’Orazione domenicale, poiché, dice san Girolamo: « È dopo l’insegnamento di Cristo stesso, che gli Apostoli hanno osato dire ogni giorno con fede, offrendo il sacrificio del suo corpo: Padre nostro che sei nei cieli».
Il Sacrificatore procede immediatamente alla Frazione dell’Ostia, facendosi in ciò imitatore non solo degli Apostoli, ma di Cristo stesso, che prese il pane, lo benedì e lo spezzò prima di distribuirlo.
Ma, prima di comunicarsi con la Vittima di carità, tutti devono salutarsi nel santo bacio. «L’invito dell’Apostolo – dice Origene – ha prodotto nelle Chiese l’uso che hanno i fratelli di scambiarsi il bacio quando la preghiera è arrivata alla fine».
Ecco quindi certificata l’origine apostolica dei riti principali del Sacrificio, così come si praticavano in tutte le Chiese.
Certificata quindi l’origine apostolica dei riti principali del Sacrificio, così come si praticavano in tutte le Chiese, da tale ricostruzione discendono alcune fondamentali conclusioni:
- la Liturgia istituita dagli Apostoli ha dovuto contenere necessariamente tutto quello che era essenziale alla celebrazione del Sacrificio cristiano e all’amministrazione dei Sacramenti, tanto sotto l’aspetto delle forme essenziali quanto sotto quello dei riti obbligatori per la decenza dei misteri, per l’esercizio del potere di Santificazione e di Benedizione che la Chiesa riceve da Cristo attraverso gli stessi Apostoli. Questo insieme liturgico ha dovuto comprendere tutto quello che si riconosce universale nelle forme del culto, nell’arco dei primi secoli, e di cui non si può designare l’autore o l’origine, secondo il su menzionato principio di sant’Agostino. Questo insieme primitivo di riti cristiani, già sufficientemente chiari e dettagliati, mostra come, sin dal suo sorgere, la Chiesa abbia avvertito la necessità di stabilire il culto con il quale doveva elevarsi il Sacrificio e la lode al Dio tre volte Santo.
- Eccezion fatta per un esiguo numero di allusioni negli Atti degli Apostoli e nelle loro Epistole, la Liturgia apostolica si trova interamente fuori dalla Scrittura, ed è di puro dominio della Tradizione. Sin dalle sue origini, dunque, la Liturgia è esistita più nella Tradizione che nella Scrittura. Ma ciò non deve meravigliare specie se si considera che la Liturgia si esercitava dagli Apostoli, e da coloro che essi avevano consacrato vescovi, sacerdoti o diaconi, molto tempo prima della redazione completa del Nuovo Testamento.
- I Padri del III e IV secolo assai di frequente, parlando di qualche rito o cerimonia in particolare, affermano che è d’origine o tradizione apostolica. Con tale espressione – che è scientificamente e storicamente inverificabile – i Padri volevano verosimilmente richiamarsi al periodo più antico della Chiesa dimostrando con ciò quanto fossero ancora vive, presso le varie Chiese, le memorie dell’attività liturgica degli Apostoli.
- In tutta l’antichità cristiana non si trova alcun indizio che accenni, come vogliono i Protestanti e certa corrente teologia, ad una diretta ingerenza delle Comunità nelle funzioni del Culto. La fissazione e la progressiva regolamentazione della Liturgia si mostra sempre compito esclusivo degli Apostoli e dei vescovi loro successori.
Alla fine del IV secolo si registrano queste pregnanti parole del papa san Siricio che rivelano tutta l’importanza dell’unità liturgica come fondamento dell’unità della Fede e del Dogma: «La regola apostolica – scrive – c’insegna che la confessione di fede dei vescovi cattolici deve essere una. Se v’è una sola fede, non vi sarà che una sola tradizione. Se v’è una sola tradizione, vi dovrà essere una sola disciplina in tutta la Chiesa». Di qui l’importanza dell’unità liturgica che è il dogma professato nelle formule sacre.
Risale proprio a questo periodo (430 ca.) il notissimo lemma, divenuto legge nella scienza liturgica: “lex orandi lex creclendi“. Se esso è a tutti noto – forse non a tutti è noto l’autore e il complesso della citazione. Sembra che risalga al papa san Celestino il quale così scriveva ai vescovi della Gallia contro l’errore dei pelagiani: «Oltre ai decreti inviolabili della Sede apostolica che ci hanno insegnato la vera dottrina, consideriamo anche i misteri racchiusi nelle formule di preghiere sacerdotali che, stabilite dagli apostoli, sono ripetute nel mondo intero in modo uniforme in tutta la Chiesa cattolica cosicché la regola della fede deriva dalla regola della preghiera: ut legem credendi lex statuat supplicandi».
In conclusione, durante i primi tre secoli del Cristianesimo, v’era una sostanziale unità di riti. Si trattava naturalmente d’un’uniformità di sostanza più che di accidenti. Gradualmente i dettagli variabili vengono fissati ed entrano nella Tradizione della Chiesa, benché il rito rimanga ancora fluido, entro però delle linee ben stabilite.
La riforma di san Gregorio Magno
Dal IV secolo in poi abbiamo informazioni molto particolareggiate sulle questioni liturgiche. Padri della Chiesa come san Cirillo da Gerusalemme (†386), sant’Atanasio (†373), san Basilio (†379), san Giovanni Crisostomo (†407) ci offrono elaborate descrizioni dei riti che si celebravano.
La libertà della Chiesa sotto Costantino e, approssimativamente, il primo concilio di Nicea nel 325 segnano il grande punto di svolta degli studi liturgici. All’incirca dal IV secolo si ebbe la compilazione di testi liturgici completi: furono compilati il primo Euchologion e i Sacramentari per l’uso in chiesa.
Nel V secolo Papi e vescovi lavorano intensamente per l’unità liturgica e il suo perfezionamento. Tale opera fu portata a compimento nel secolo seguente da quel Pontefice il cui nome sarebbe rimasto per sempre legato alla sacra Liturgia: san Gregorio Magno. Asceso al soglio pontificio nel 590, intraprese molte importanti riforme, tra le quali quella della Liturgia fu senza dubbio preminente. La nota dominante della sua riforma fu la fedeltà alla Tradizione.
Sono ben noti i criteri liturgici del Santo. Egli scrive ad Agostino di Canterbury di scegliere, pur liberamente dalle chiese franche, quegli usi rituali che avesse stimato più convenienti per i suoi neofiti angli, giacché: non pro locis res, sed pro rebus loca amanda sunt. E in un’altra lettera diretta al vescovo Giovanni di Siracusa, si dichiarò disposto ad applicare questo principio alla stessa Liturgia romana: e in ciò Gregorio seguiva perfettamente la tradizione dei suoi predecessori, tanto che la Liturgia di Roma entrò definitivamente nel suo periodo di stasi solo dopo la morte del grande Dottore. «Se essa stessa (la Chiesa di Costantinopoli) – scrive san Gregorio – o un’altra Chiesa ha qualcosa di buono, io sono pronto ad imitare nel bene anche coloro che sono più piccoli di me, che tengo lontani da ciò che non è lecito. Infatti è stolto colui che si ritiene primo tanto da non voler imparare ciò che ha visto di buono».
Ma il patrimonio liturgico della Sede apostolica non cedeva in splendore a quello di alcun’altra Chiesa; per cui san Gregorio ci attesta che le sue innovazioni nella Messa in realtà non furono altro che un ritorno alle più pure tradizioni romane. Non fu neppure una vera innovazione quella d’aver dato una maggior importanza a quell’estremo residuo della primitiva prece litanica (Kyrie, eleison), che originariamente seguiva l’ufficio vigiliare, prima d’incominciare l’anafora eucaristica. All’introito san Gregorio riattaccò il Kyrie, ottenendo così che la Colletta sacerdotale non mancasse totalmente d’una qualsiasi formula di preambolo.
Fu parimenti Gregorio quello che anticipò prima della frazione delle Sacre Specie consacrate il canto dell’Orazione Domenicale, perché servisse quasi di conclusione al Canone eucaristico, giacché originariamente, così ragionava il Santo, l’anafora consacratoria includeva in qualche modo l’Orazione che il Signore stesso aveva insegnato agli Apostoli, come vedremo tra breve.
Fin dai tempi di san Paolo, l’unità della famiglia cristiana, sotto il governo dei legittimi pastori, era simboleggiata dall’unità dell’altare, del pane e del calice eucaristico, del quale tutti insieme partecipavano. Ma perché il senso dell’unità dell’Ecclesia romana non venisse indebolito dalle successive divisioni di carattere puramente amministrativo, in ciascuna domenica il Pontefice inviava ai suoi presbiteri una particella consacrata della sua Eucharistia, perché, deposta nel loro calice a guisa di sacrum fermentum, simboleggiasse l’identità del Sacrificio e del Sacramento che riuniva in una sola Fede le pecore e il pastore. L’ultimo ricordo di questo rito è appunto il frammento eucaristico che anch’oggi si depone nel calice dopo la frazione dell’Ostia.
San Gregorio visse in un periodo storico caratterizzato non solo dal flagello della peste, ma anche dalla guerra e dal terremoto, onde il Pontefice s’offrì al Signore vittima d’espiazione per i peccati del popolo. Egli perciò affidò le sorti d’Italia ai disegni della Provvidenza e, nella preghiera eucaristica, poco prima della consacrazione dei divini Misteri, là dove la Liturgia romana era solita di enunciare “le intenzioni particolari giusta le quali veniva offerto il Sacrificio”, aggiunse il voto supremo del suo cuore di pastore: « diesque nostros in tua pace disponas», parole che il Canon Missæ conserva quale preziosa eredità di san Gregorio Magno.
Dopo di lui c’è poco da raccontare sulla natura dei cambiamenti dell’ordinario della Messa, divenuto un’eredità sacra ed inviolabile dalle origini immemorabili. Era popolare l’opinione secondo la quale l’ordinario era rimasto immodificato fin dal tempo degli Apostoli, se non addirittura dallo stesso Pietro.
Adrien Fortescue ritiene che il regno di san Gregorio Magno segni un’epoca nella storia della Messa, avendo lasciato la Liturgia, nei suoi elementi essenziali, del tutto simile a quella praticata oggi. Scrive: «C’è, inoltre, una tradizione costante secondo la quale san Gregorio fu l’ultimo a intervenire sulle parti essenziali della Messa, cioè sul Canone. Benedetto XIV (1740-1758) dice: “Nessun papa ha aggiunto o cambiato qualcosa nel Canone da san Gregorio in poi”».
Se ciò sia del tutto vero non è di grande rilievo; il dato fondamentale è che nella Chiesa Romana certamente è esistita una tradizione ultramillenaria secondo cui il Canone non si sarebbe mai dovuto cambiare. Secondo il cardinal Gasquet «il fatto che sia rimasto inalterato per tredici secoli è la testimonianza più clamorosa della venerazione con la quale è sempre stato guardato e dello scrupolo che è sempre stato avvertito nel toccare un’eredità tanto sacra, giunta a noi da tempi immemorabili».
Anche se il rito della Messa continuò a svilupparsi – nelle parti non essenziali – dopo l’epoca di san Gregorio, il Fortescue spiega che «tutte le successive modifiche furono adattate entro l’antica struttura e le parti più importanti non furono toccate. All’incirca dal tempo di san Gregorio conosciamo il testo della Messa, l’ordinario e l’allestimento, come tradizione sacra che nessuno ha osato alterare eccetto che per alcuni dettagli ininfluenti». Tra le aggiunte più recenti «le preghiere ai piedi dell’altare sono, nella loro attuale forma, l’ultima parte di tutta la Messa. Si svilupparono da preparazioni private medievali e non erano state formalmente stabilite, nella loro forma attuale, prima del Messale di Pio V (1570)». Furono comunque largamente usate ben prima della Riforma e si rinvengono nella prima edizione stampata del Messale Romano (1474).
Il Gloria fu introdotto gradualmente, prima soltanto in forma cantata nelle Messe festive dei vescovi. È probabilmente di origine gallicana. Il Credo giunse a Roma nel secolo XI. Le preghiere dell’Offertorio e il Lavabo furono introdotti d’oltralpe difficilmente prima del XIV secolo. Placeat, Benedizione e Ultimo Vangelo furono introdotti gradualmente in epoca medievale».
Va comunque notato che queste preghiere, pressoché invariabili, prima della loro incorporazione ufficiale nel rito romano, avevano acquistato un uso liturgico secolare.
Il Rito Romano si andò poi rapidamente diffondendo, e nell’XI e XII secolo in Occidente praticamente soppiantò tutti gli altri riti, salvo quello di Milano e di Toledo. Ciò del resto non deve sorprendere: se la Chiesa di Roma era universalmente considerata la guida nella Fede e nella Morale, questo ruolo primaziale rivestiva anche in materia liturgica. La Messa, nell’Alto Medioevo, era già considerata un’eredità inviolabile, le cui origini si perdevano nella notte dei tempi. Meglio, era comunemente ritenuto che essa risalisse agli Apostoli o – come già affermato – che fosse stata redatta dallo stesso san Pietro.
Ne segue che l’Ordo Missæ riportato nel Messale di san Pio V (1570), a parte alcune aggiunte e allargamenti minimi, corrisponde molto da vicino all’Ordo stabilito da san Gregorio Magno.
Il Concilio di Trento
Nei secoli intercorsi dalla riforma di san Gregorio Magno fino al Concilio di Trento, il Rito Romano si diffuse in tutto l’orbe cattolico senza che ciò ostacolasse il fiorire di usi locali, i quali si svilupparono in modo graduale e naturale nel corso di molti secoli. Con il passare del tempo preghiere e cerimonie si moltiplicarono quasi impercettibilmente e, in ogni caso, al loro sviluppo seguiva la selezione e l’eventuale codificazione, cioè l’incorporazione di queste preghiere e cerimonie nei libri liturgici. Uno dei più grandi storici della Britannia, Owen Chadwick, osservò che: «Le Liturgie non sono fatte, esse crescono nella devozione dei secoli».
Mille anni circa dopo la riforma di san Gregorio Magno, togliendo le aggiunte marginali avvenute nel corso dei secoli, san Pio V, in seguito alla Riforma protestante e al Concilio di Trento, diede alla stessa Messa di san Gregorio Magno una forma definitiva da valere per sempre e dovunque.
La pratica di riferirsi alla Messa tradizionale del Rito Romano come Messa Tridentina è poco felice poiché ha portato alla diffusa ed erronea impressione che questa Messa sia stata composta in seguito al Concilio di Trento. La parola “Tridentina”, in realtà, significa “riguardante” questo Concilio – Concilium Tridentinum – che ebbe luogo in diversi periodi tra gli anni 1545 e 1563. II Concilio di Trento, in realtà, stabilì una commissione per esaminare il Messale Romano, rivederlo e ripristinarlo «secondo l’usanza e il rito dei Santi Padri». Il nuovo Messale fu, infine, promulgato da papa san Pio V nel 1570 con la bolla Quo Primum. Il lavoro preparatorio della Commissione fu caratterizzato dal rispetto per la Tradizione. In nessun caso ci fu la minima proposta di comporre un Novus Ordo Missæ. La sola idea era ritenuta inconcepibile all’autentico sentire cattolico. La Commissione codificò il Messale esistente, eliminando alcuni punti che considerava superflui o non necessari e conservando i riti esistenti da almeno duecento anni. Tuttavia, per quanto riguardava l’Ordinario, il Canone, il Proprio del Tempo, e molto più, era una replica del Messale Romano del 1474, che, in tutte le cose essenziali, risaliva all’epoca di san Gregorio Magno.
Il Fortescue fa particolare menzione della continuità liturgica che caratterizzò il novello Messale, il quale, promulgato da san Pio V, non è semplicemente un decreto personale del Sovrano Pontefice ma un atto del Concilio di Trento, sebbene chiuso il 4 dicembre 1563, prima che la Commissione avesse terminato il suo compito. La questione fu rimessa a papa Pio IV, che morì prima di concludere il lavoro; così fu il successore, san Pio V, a promulgare il Messale risultante dal Concilio, con la sopra menzionata Bolla.
Poiché il Messale è un atto del Concilio di Trento, il suo titolo ufficiale è Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum (Messale Romano restaurato secondo i decreti del Sacrosanto Concilio Tridentino). Per la prima volta in millecinquecento anni di storia della Chiesa un concilio e/o un papa specificarono ed imposero un rito completo della Messa attraverso lo strumento legislativo.
Il Fortescue, studiando accuratamente la riforma di san Pio V, giunse alla seguente conclusione: «Possiamo essere veramente grati alla commissione che fu così scrupolosa nel mantenere o restaurare l’antica tradizione Romana». Aggiunse poi che «fin dal Concilio di Trento la storia della Messa è, in sostanza, nient’altro che la composizione e l’approvazione di nuove Messe (proprie, ndr). Lo schema e tutte le parti fondamentali rimangono le stesse. Nessuno ha pensato di toccare la venerabile Liturgia della Messa Romana eccetto che nell’aggiungere ad essa nuovi Propri». «Non c’è nella cristianità un altro rito sì venerabile come il nostro», asserisce il Fortescue. È quindi la Messa Tridentina, il rito più venerabile nella Cristianità, « la cosa più bella da questa parte del cielo», come si espresse padre Faber. Scrivendo di questa Messa, John Henry Newman osservò: «Niente è così consolante, così commovente, così toccante, così esaltante, quanto la Messa, così com’è celebrata tra noi […]. Non si tratta di una formula verbale, è una grande “azione”, la più grande che possa esserci sulla terra. È […] l’evocazione dell’Eterno. Diventa presente sull’altare in carne e sangue Colui davanti al quale si prostrano gli angeli e tremano i demoni».
Un nuovo Messale?
Il primo scopo del Concilio di Trento – come s’è detto – fu quello di codificare l’insegnamento eucaristico cattolico; cosa che fece in modo eccellente ed in termini chiari ed ispirati, pronunciando l’anatema per chiunque avesse rifiutato quell’insegnamento. «Così il Concilio insegna la vera e genuina dottrina sul venerabile e divino sacramento dell’Eucaristia, quella dottrina che la Chiesa Cattolica ha sempre fermamente amato e che amerà fermamente fino alla fine del mondo, come è stata insegnata da Cristo Nostro Signore stesso, dai suoi Apostoli e dallo Spirito Santo, che continuamente porta alla sua mente [della Chiesa, ndt] tutta la verità. Il Concilio vieta a tutti i fedeli a Cristo, d’ora in poi, di credere, insegnare o predicare sulla Santissima Eucaristia qualunque cosa diversa da quanto spiegato e definito nel presente decreto».
Nella XVIII sessione, il Concilio incaricò una commissione di esaminare il Messale, rivederlo e restaurarlo «secondo l’usanza ed il rito dei Santi Padri». Il Fortescue ritiene che i membri della commissione incaricata della revisione del Messale «portarono a termine il loro compito molto bene»: «Non fu la creazione di un nuovo Messale ma la restaurazione dell’esistente “secondo l’usanza ed il rito dei Santi Padri”, con l’uso, a tale scopo, dei migliori manoscritti e di altri documenti».
Non si trattò dunque di un nuovo Messale. La sola idea di comporne uno ex novo era ed è totalmente aliena a tutto il sentire cattolico. Il cardinal Gasquet osservò che: «Ogni cattolico deve sentire un amore personale per i sacri riti che arrivano a lui con tutta l’autorità dei secoli. Ogni manipolazione grossolana di tali forme causa un dolore profondo in chi le conosce e le usa, perché esse giungono da Dio attraverso Cristo ed attraverso la Chiesa. Ma non eserciterebbero tanta attrazione se non fossero santificate dalla devozione di tante generazioni che hanno pregato con le stesse parole ed hanno trovato in esse fermezza nella gioia e consolazione nel dolore».
L’essenza della riforma di san Pio V fu, come quella di san Gregorio Magno, il rispetto della tradizione. Nel 1912 padre Fortescue poteva commentare con soddisfazione: « …la restaurazione di san Pio V fu una delle più eminentemente soddisfacenti. Lo standard della commissione fu l’antichità. Furono abolite le forme elaborate più recenti e fu scelta la semplicità, pur senza distruggere tutti quegli elementi pittoreschi che aggiungono bellezza poetica alla severa Messa Romana. Furono eliminate le numerose lunghe sequenze che si accalcavano continuamente nella Messa, ma furono mantenute le cinque sicuramente migliori. Furono ridotte le processioni con i cerimoniali elaborati, pur salvando le cerimonie veramente significative: la Candelora, le Ceneri, le Palme ed i bellissimi riti della Settimana Santa. Sicuramente, in Occidente, possiamo essere molto contenti di avere il Rito Romano nella forma del Messale di san Pio V».
Dal tempo della riforma di san Pio V ci sono state revisioni, mai però sostanziali. Talvolta quelle che oggi sono citate come “riforme” non furono altro che restaurazioni del Messale nella forma codificata da san Pio V. Ciò è vero in particolare per le “riforme” di Clemente VIII, stabilite nell’istruzione Cum sanctissimum del 7 luglio 1604, e di Urbano VIII nell’istruzione Si quid est, del 2 settembre 1634. San Pio X operò una revisione non del testo, bensì della musica.
Tra il 1951 e il 1955 Pio XII riformò le cerimonie della Settimana Santa (con il decreto Maxima redemptionis) e autorizzò una revisione delle rubriche orientata principalmente al calendario. Anche papa Giovanni XXIII operò un’estesa riforma delle rubriche che fu promulgata il 25 luglio 1960 ed ebbero effetto dal 1° gennaio 1961, ancora una volta incentrata soprattutto sul calendario. Nessuna di tali riforme comportò qualche significativo cambiamento nell’Ordinario della Messa.
Nel 1929, infatti, il cardinal Schuster aveva potuto scrivere: «Paragonando l’attuale messale nostro dopo la riforma tridentina con il messale medioevale e col Sacramentarlo Gregoriano, la differenza non appare punto sostanziale. Il nostro è più ricco e vario per ciò che riguarda il ciclo agiografico; ma le Messe stazionali delle domeniche, dell’Avvento, della Quaresima, delle feste dei Santi comprese nel Sacramentario di san Gregorio, salvo poche differenze, sono quasi le stesse. Si può dire insomma che il nostro codice eucaristico, pur tenuto conto dello sviluppo raggiunto con il decorrer dei secoli, è sostanzialmente il medesimo che usavano i grandi Dottori della Chiesa nel Medio Evo, e che recava in fronte il nome di Gregorio Magno».
Conclusione
La Messa cosiddetta “tridentina” ha un nucleo centrale immutabile, stabilito da Cristo stesso, continuato e perfezionato dagli Apostoli e conservato intatto attraverso due millenni di storia. La trama di riti e di cerimonie che la caratterizza s’è andata evolvendo poco a poco fino a raggiungere una forma quasi definitiva alla fine del III secolo, poi resa in qualche modo definitiva da san Gregorio Magno. Non sono mancati elementi secondari: la sollecitudine materna della Chiesa non ha cessato di restaurare ed abbellire il rito, rimuovendo di tanto in tanto quelle scorie che minacciavano offuscarne il primitivo splendore.
Questa la storia della Messa fino alla promulgazione del Nuovo Messale nel 1969. Gli eminentissimi cardinali Bacci e Ottaviani nel Breve esame critico del Novus Odo Missæ presentato al pontefice Paolo VI, prima della definitiva promulgazione, non esitarono ad affermare che il NOM (Novus Ordo Missæ) «considerati gli elementi nuovi, suscettibili di pur diversa valutazione, che vi appaiono sottesi ed implicati, rappresenta, sia nel suo insieme come nei particolari, un impressionante allontanamento dalla teologia cattolica della Santa Messa, quale fu formulata nella Sessione XXII del Concilio Tridentino, il quale, fissando definitivamente i canoni del rito, eresse una barriera invalicabile contro qualunque eresia che intaccasse l’integrità del magistero».
In una nota del “breve esame” in questione viene riportata una citazione di padre Louis Bouyer secondo cui «il Canone romano risale, tale e quale è oggi, a san Gregorio Magno. Non vi è, in Oriente come in Occidente, nessuna preghiera eucaristica che, rimasta in uso fino ai nostri giorni, possa vantare una tale antichità! Agli occhi non solo degli ortodossi, ma degli anglicani e persino dei protestanti che hanno ancora in qualche misura il senso della tradizione, gettarlo a mare equivarrebbe, da parte della Chiesa Romana, a rinnegare ogni pretesa di rappresentare mai più la vera Chiesa Cattolica» (nota 1).
Romano Amerio, nel suo insuperato Iota Unum, scrive che «leggendo le antiche liturgie, come il Sacramentario di Biasca, che è del secolo IX, e ritrovandovi le formule con cui la Chiesa Romana orò per oltre un millennio, si sente vivamente la iattura subita dalla Chiesa spogliatasi del senso dell’antiquitas che, persino secondo i Gentili, proxime accedit ad deos, nonché del senso dell’immobilità del divino nel moto del tempo».
Il cardinal Ratzinger già anni fa denunciava che – con la riforma Liturgica post-conciliare – si era sostituita «una Liturgia sviluppatasi nel tempo con una Liturgia costruita a tavolino». «La promulgazione del divieto del messale – affermava ancora il Porporato – che si era sviluppato nel corso dei secoli, fin dal tempo dei sacramentali dell’antica Chiesa, ha comportato una rottura nella storia della Liturgia, le cui conseguenze potevano solo essere tragiche. […] si fece a pezzi l’edificio antico e se ne costruì un altro […]; il fatto che esso sia stato presentato come edificio nuovo, contrapposto a quello che si era formato lungo la storia, che si vietasse quest’ultimo e si facesse in qualche modo apparire la Liturgia non più come un processo vitale, ma come un prodotto di erudizione specialistica e di competenza giuridica, ha comportato per noi dei danni estremamente gravi. In questo, modo, infatti, si è sviluppata l’impressione che la Liturgia sia “fatta”, che non sia qualcosa che esiste prima di noi, qualcosa di “donato”, ma che dipenda dalle nostre decisioni. Ne segue, di conseguenza, che non si riconosca questa capacità decisionale solo agli specialisti o a un’autorità centrale, ma che, in definitiva, ciascuna “comunità” voglia darsi una propria Liturgia. Ma quando la Liturgia è qualcosa che ciascuno si fa da sé, allora non ci dona più quella che è la sua vera qualità: l’incontro con il mistero, che non è un nostro prodotto, ma la nostra origine e la sorgente della nostra vita».
Bernardo di Chartres diceva che «noi siamo come nani che stanno sulle spalle dei giganti, così che possiamo vedere più lontano di loro non a causa della nostra statura o dell’acutezza della nostra vista, ma perché, stando sulle loro spalle, stiamo più in alto di loro». Dio ci doni l’umiltà di riconoscerci nani, e l’intelligenza se vogliamo veder lontano – di rimanere sulle spalle di quei giganti che sono i nostri Padri nella Fede. Senza questo atteggiamento della mente e del cuore ci condanniamo da soli ad una certa e forse irreversibile cecità.
____________________________
[Fonte: Il Settimanale di Padre Pio, 2011/nn. 22 (p.13-14); 23 (p. 12-13); 24 (p. 12-13); 25 (p.22-23); 26 (p.15-17); 27 (p. F3-14); 28 (p. 18-19); 29 (p.16-19)].
dal sito chiesaepostconcilio.blogspot.it